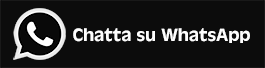Falstaff, la rivincita di Rigoletto
In quattro secoli ha avuto tanti discendenti da farci dimenticare che l'originale è lui: Falstaff, l'archetipo del grassone simpatico. Un bellimbusto taglia XXL, narciso e sbruffone più di Pietro del Grande Fratello, vizioso e manilunghe come Benny Hill, filosofo come un Cyrano terragno.
Falstaff è esistito davvero. Si chiamava Sir John Oldcastle ed era il capo della setta religiosa dei Lollardi. Shakespeare lo porta in teatro nel 1598 nell'Enrico IV. Per evitare grane con i discendenti gli cambia nome. Il successo è tale che nel 1602 una regina Elisabetta capricciosa come quella di Shakespeare in Love chiede di rivedere il "grasso cavaliere innamorato". Il Bardo fa del suo meglio, ma il Falstaff di The Merry Wives of Windsor esce sfocato. Per questo Arrigo Boito fa un patchwork dei due titoli. Risultato: il libretto per Verdi è uno dei pochi casi in cui la riduzione batte l'originale, Italia 1 - Inghilterra 0. Non ditelo oltremanica, ma il vero Falstaff è il nostro.
Prima di Verdi, il pingue era già stato protagonista di Falstaff o sia Le tre burle di Antonio Salieri (1799), di Falstaff di Michael William Balfe (1838) e di Die Lustigen Weiber von Windsor di Otto Nicolai (1849). Dopo il rifacimento del Simon Boccanegra e Otello, Falstaff è la terza opera nata dalla collaborazione con Arrigo Boito (1842-1918), la prima in cui il brillante poeta, critico e musicista infonde i suoi funambolismi linguistici e le sue prodezze metriche in una commedia. L'estremo capolavoro di Verdi diventa così la sua prima opera comica dal remoto Un giorno di regno del 1840, una farsa con ancora i crescendo rossiniani e i recitativi secchi al fortepiano.
Però andiamoci piano. Quello d'un Verdi che per tutta una vita fa cantare moribondi in scena e poi affida il suo testamento a una risata che mai gli era uscita prima è un mito da ridimensionare. Se Verdi non scrive commedie è soprattutto perché ai tempi di Un giorno di regno l'opera buffa era già al capolinea. Almeno quella di serie A. Dopo Don Pasquale i vari Ricci e Cagnoni non fanno altro che ripetere le stantie cabalette di Donizetti. Verdi conosce il potere del comico: riascoltiamo l'introduzione di Rigoletto fino all'ingresso di Monterone o Fra Melitone nella Forza del Destino. Solo che lì la commedia o serve a scatenare il dramma o resta un cameo isolato. Del comico, quello che a Verdi non torna, è il rapporto fra le cause drammatiche e i procedimenti destinati a tradurle in esiti scenici: un nodo su cui sarà sempre intransigente nello scegliere i soggetti, nel limare i versi con i librettisti e con se stesso nello scrivere note.
Falstaff prende forma dal 1891 e debutta alla Scala il 9 febbraio 1893. Il ritorno del Grande Vecchio è un successo europeo, preparato da Ricordi con un lungo battage giornalistico, una sagace opera di marketing e qualche intoppo. Come l'esorbitante cachet richiesto dal protagonista Victor Maurel, il baritono che nel 1887 aveva creato Jago, poi ricondotto a miti consigli.
Falstaff è la commedia del declino. In un Medioevo al tramonto, sir John vegeta all'Osteria della Giarrettiera, tasche e boccale sempre a secco, gonfio d'orgoglio e dell'illusione di mantenere a scrocco i famelici e bifidi Bardolfo e Pistola. John Falstaff è un sopravvissuto del secolo dei cavalieri, dell'armi e degli amori. Non accetta i segni evidenti della decadenza fisica. Rifiuta un mondo tutto cambiato e che lo emargina: quello della moderna borghesia mercantile che compra la felicità a peso d'oro, il mondo del rivale Ford ("un gran borghese, un Creso, un Lord") e delle sue donne belle e impossibili. È qui il motore delle sue imprese di ghiottone e seduttore oltre i confini del lecito. Dalla crapula in casa del Dottor Caius ai tentativi goffi e frustrati di conquistare Alice Ford e Meg Page, tutte le azioni di Falstaff sono sospinte da una forza oscura: l'ansia di sfuggire alla morte, l'assillo vitalistico di piacere ancora, l'ossessione di difendere con il cibo e il vino un regno vasto solo come la sua epa.
Falstaff spiana la strada al Novecento. Dei vecchi ruoli e triangoli del melodramma ancora vivi in Otello non c'è più traccia. L'unica coppia tradizionale è Fenton-Nannetta, che sopravvive in quanto semplice opposizione giovani-vecchi e conserva per questo le sue oasi liriche anche nel fragore dei concertati. Falstaff è un'opera estrema, trasumanata, intellettuale: ma il suo intellettualismo non è mai fine a se stesso, né quando Fenton nel terzo atto intona un sonetto shakespeariano sul viaggio metafisico d'un bacio, né quando Verdi fa cantare la morale finale su una forma-teorema come la fuga. Né tantomeno quando il verso virtuosistico di Boito viene negato e disatteso di continuo da una prosa musicale che insegue sillaba per sillaba il ritmo del parlato.
In Falstaff infatti si canta, e molto. Se in Otello domina la melodia infinita, qui riaffiorano forme liriche familiari come arie e duetti. Solo che sono scatole vuote, recuperate come trovarobato postumo. È già l'estetica della "musica al quadrato" di Stravinskij: "L'amor che non ci dà mai tregue" è un fantasma di madrigale, "Quand'ero paggio" uno spettro di cabaletta che, guarda caso, in teatro una vecchia tradizione faceva istintivamente bissare.
In questo puro gioco di forme, per il vecchio e disilluso Verdi come per Falstaff tutto è apparenza, illusione, burla. Se Wagner aveva impiegato una vita a dare espressione al vero, lui, più cinico, aveva capito per tempo. Una lettera del 1876: "Copiare il vero può essere una buona cosa, ma inventare il vero è meglio, molto meglio".
Nicola Gallino (da www.sistemamusica.it)