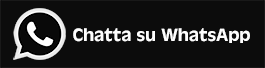La Messa in si minore e la pipa di Bach
Siamo poco abituati a sentir cantar di Dio, e così a lungo, ma chissà se, in fondo all'anima, non ne abbiamo ancora un gran bisogno. La quasi totalità della musica che risuona in questi tempi nelle nostre chiese non eleva da terra, anzi cerca continuità con il clima canzonettistico che echeggia nei bar che si affacciano appena fuori del sagrato, ritmata da un grattare triste di chitarre che vorrebbe attrarre al culto gli indifferenti per mezzo di suoni familiari. Con il risultato frequente di lasciare oltre il portone i sensibili. Non sembra condivisa la necessità di offrire un paesaggio sonoro "altro" rispetto a quello del mondo, dove il tempo ordinario sia sospeso e uno nuovo si spieghi. Per fortuna la musica rappresenta un luogo di culto a sé, che non risponde a confessioni, non si piega a dettami conciliari: la bellezza dell'arte sta nel lasciare ciascuno libero di inseguire un'idea di Dio che, tra le maglie di un tessuto narrativo perfetto, serbi intatto un sentimento di vago mistero, sta nel saper immergere l'individuo in un milieu corale senza mortificare la sua unicità. La Messa in si minore di Johann Sebastian Bach è un buon esempio di tutto questo. L'opera, scritta a più riprese in un arco di quindici anni e risultato dell'accostamento di molto materiale di riuso, non è per cattolici né per protestanti, non è utile per alcun ufficio liturgico, non serve quindi per reclutare nuovi adepti: chi vorrà ascoltare questa lunga dissertazione non si sentirà imporre alcun'idea dogmatica della trascendenza, ma solo un'esperienza temporale mistica. Alla fine del concerto non ci capaciteremo di quante ore saranno trascorse, perché non ci sono secondi, minuti, ma solo un susseguirsi di creature transitorie che nascono, si muovono e spirano e in ognuna si troverà un movimento dominante che è anche nostro e insieme è più armonioso del nostro; si coglierà uno stato d'animo tra quelli vissuti, descritto nei suoi tratti più universali, quelli che avremmo voluto, invano, compatire con i nostri prossimi; troveremo inflessioni intonative che abbiamo usato per raccontarci di passioni e di dolori, ma disposte secondo un ritmo sul quale tutti si possono sincronizzare, anche gli dei; l'inseguirsi di voci e strumenti nei frequenti episodi fugati accumulerà tensione drammatica, ma in bell'ordine, senza il caos con il quale si affastellano i temi delle nostre vite. Anche Bach si serve di modelli stilistici cortigiani allora in voga, ma li sacralizza con il rigore del gusto, li filtra attraverso il crivello della sua solida fede personale: adatta Cantate che inneggiano con profano vitalismo, utilizza corni da caccia per impastare di colore jus de tabac la voce del basso nel Quoniam o l'oboe d'amore nel Kyrie, per ornare gli affetti con scie di calore cortese; lascia che siano due soprani a invocare pietà al Christe-Homo con operistici, luminosi arabeschi e un contralto, nel Gloria, a lodare Iddio con seducenti virtuosismi effusivi rinforzati dal violino solista, che le semina intorno gesti rapidi e incisivi come formule magiche. Non mancano sfavillii barocchi di trombe e trionfi di timpani in tonalità brillanti in onore di un magniloquente potere temporale piuttosto che spirituale. Ma momenti più alti sono quelli che cantano la pochezza dell'uomo. La chiave di volta del corpus architettonico è il Credo, un racconto teso ed emotivamente sorprendente, che serba il suo momento più intenso per un disegno a cuspide rovesciata verso il basso, discendente lungo coni d'ombra e povertà. Bach affida questo quadro contemplativo di mestizia e stupore a un coro a cinque voci compresso attorno a un incedere di violini faticoso e greve per sottolineare l'incarnazione, mistero più enigmatico di quello della risurrezione: il divino che si fa nulla. In una poesiola nel quaderno di cembalo della moglie Anna Magdalena, Bach scrive della sua amata pipa come "creatura impastata di terra fangosa e altra acqua, e a null'altro destinata che a spezzarsi a terra prima o poi e a terra ritornare". Anche la musica di quest'uomo nei suoi momenti più alti non fa che parlare di come l'essere sia terra e del suo unico modo per elevarsi: produrre bellissimi anelli di fumo.
Gianni Nuti (da www.sistemamusica.it)