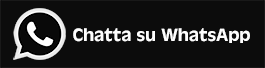L'ultimo Beethoven
Quando il 26 marzo 1827 Beethoven trapassò nel luogo del perfetto silenzio, nello spazio dell'assoluta fantasia, già da tempo questo mondo gli era molto distante. Ai suoi occhi, tutto ciò che era umano, antropomorfico, tutto ciò che apparteneva a questa nostra dolcissima terra, nascondeva qualcosa di limitato, qualcosa di insufficiente e ambiguo. L'antitesi, il contrasto, il doppio, permeavano le innumerevoli forme dell'esistenza, fino a trasformarle in qualcosa ora di assolutamente buono ora di irriducibilmente cattivo. Soltanto la musica aveva il dono di impossessarsi di queste forze, di manipolarle, di guidarle, di mutarle, facendo intuire quel perfetto spirito, quell'assoluto spazio - insieme geometrico e organico, concreto e astratto - che trascina le nostre anime in un gorgo di felicità e commozione. Poco prima di quel fatidico momento, durante la sua ultima visita, un amico gli aveva detto: "La morte non è nulla, non si vive nella vita che per qualche istante, e sono i momenti più belli. Ciò che vive veramente nell'uomo è eterno. Ciò che passa non ha alcun valore. Ciò che grande e bella può fare questa vita è la fantasia, un fiore che si apre interamente solo nell'altro mondo.
Vicino al nodo dell'esistenza stessa, sulla soglia del portale enigmatico dell'aldilà, Beethoven, come Schelling, aveva sentito più forte il richiamo dell'estremo silenzio, l'eco di quella musica "nella sua pura essenza, spoglia della materia sonora", che sovrasta ogni limite di tempo e spazio. Quella musica senza suoni che aveva ascoltato da ragazzo in una notte di plenilunio, verso mezzanotte, seduto con un amico su di un balcone prospiciente il Danubio in piena, mentre in lontananza, si percepiva appena il sussurro rarefatto delle praterie e dei boschi. L'immagine del silenzio era sempre stata una delle componenti centrali del suo comporre. Certo, nella drammatica presenza della sordità: una malattia fisiologica, una entità simbolica; ma anche come rigore e parsimonia del materiale sonoro stesso, come tensione organica e autentica, misteriosa superficie delle pause; come modellato interiore che permette lo scavo e l'esatta curva della frase. Era stata, quell'immagine, soprattutto attraverso la sua nobile intransigenza, l'irraggiungibile ideale di una tensione inesausta verso il suono assoluto. Se il mondo delle apparenze, dei limiti, delle costrizioni, era soltanto un mediocre riflesso dell'universo delle Idee, unicamente l'arte, e la musica, potevano in qualche modo percepire ed intuire il vero mondo, il luogo inarrivabile della verità. Quanta musica, prima di lui, si era composta senza questa tensione metafisica; senza questo rigore spirituale. Quanti melodrammi, sonate, concerti, si erano prodotti, senza una autentica dimensione morale. Come era pensabile la concezione di un suono soltanto per diletto o per divertire? Com'era concepibile il giuoco delle forme invisibili, le capriole scintillanti di una ineffabile colonna di fumo, senza il nerbo dell'ispirazione, il cuore dell'attenzione! Ciò che sembrava essere soltanto una superficie di sensazioni, priva di logica e significato; ciò che era stato considerato soltanto un elemento di second'ordine, un sottofondo d'accompagnamento sempre subordinato alla preghiera, alla parola, allo spettacolo o alla danza, per lui nascondeva qualcosa di centrale: in una forma che sapeva imporsi come una "rivelazione superiore ad ogni sapienza e filosofia." Come un simbolo, una montagna altera e fascinosa nella sua vertiginosa altezza, così la sua concezione musicale si pone tra la terra ed il cielo, l'uomo e il divino, come una presenza imprescindibile ed astratta, mitica e reale.
Sentendo le forze della notte avvicinarsi, il 17 settembre 1824 all'editore Schott aveva scritto: "Apollo e le Muse non vorranno ancora consegnarmi alla morte poiché io debbo loro ancora molto e prima della mia andata ai Campi Elisi devo lasciare dietro di me ciò che lo spirito mi ispira e mi ingiunge di terminare. Mi pare di aver scritto sinora soltanto qualche nota." Costringendo la sua ispirazione ad un vaglio molto severo, e sforzandosi senza sosta di comporre solo il necessario, certo aveva scritto ben poche note, se confrontate con la produzione vastissima degli autori precedenti. Ciò che lo spirito gli dettava, quello che le forze superiori gli suggerivano alla mente, era estremamente difficile da fissare e realizzare sulla carta. Era un misterioso potere che lo costringeva ad esprimere cose che lui stesso non penetrava interamente, "e la cui significazione è infinita." Era l'unica, estrema rivelazione: "il miracolo che dovrebbe persuaderci dell'assoluta realtà di quest'essere supremo." Era l'autentica, vera opera d'arte che in maniera indipendente "supera l'artista stesso, per ritornare nell'atto della sua apparizione al Divino." "Non c'è nulla di più alto - aveva scritto all'arciduca Rodolfo - che avvicinarsi, più degli altri uomini, alla Divinità, e di là spandere i raggi del Divino sugli altri uomini." In questo senso, la musica era la porta immateriata attraverso la quale "si accede ad un mondo superiore della conoscenza", dove sulle ali del canto, si ha la certezza "di un mondo più completo di quello che noi esprimiamo in parole", un universo in cui ciò che si crea e si costruisce, oltre il frammento, trova il tempio del Sacro e la vita della "vera resurrezione."
In questa assoluta tensione, in questo gioco dialettico, non sempre era facile agire con serenità, misura, equilibrio. Quale contrasto c'era tra la vita domestica, le seccature delle faccende quotidiane, e i moti di questa metafisica ispirazione! Quale incomprensioni e fratture si producevano tra lo spazio delle rivelazioni e il mondo della necessità! Prigioniero come Dedalo nel labirinto delle apparenze, anche lui ogni volta doveva inventarsi le ali per volare e liberarsi. Spesso sentiva dire "che l'arte è lunga e la vita breve", ma come ci si sbagliava. In realtà, lunga è la vita e così breve è l'arte; poiché il soffio magico che ci eleva fino agli dei non dura che "per un istante." Contemplando la volta celeste, dove durante le notti serene il cielo non faceva economia dei fuochi delle stelle; o immergendosi negli immensi spazi dei campi o nell'ombra fascinosa dei boschi, il suo spirito si esaltava. Allora, dal centro del suo entusiasmo lanciava ipotetiche melodie in tutte le direzioni, le inseguiva con pazienza, le modellava, le elaborava, vedendole poi scomparire nel calore delle diverse emozioni. Più tardi riapparivano con rinnovata passione unendosi in una idea definitiva. Era un pensiero musicale, era una sonata, una sinfonia. Ma com'era difficile esprimere "quei fuochi nell'azzurro"! Com'era complicato riflettere quelle magiche e remote luci! Talvolta, scrivendo, si sentiva terribilmente deluso; gettava a terra il foglio appena scarabocchiato, quasi convinto che non c'era superficie bianca che potesse esprimere "mediante i suoni, le note, i colori, le immagini celesti che la sua fantasia eccitata aveva visto fluttuare in quell'ora benedetta." Forse i pittori ed i poeti erano più fortunati di lui, poiché i loro mezzi erano in qualche modo meno limitati, più precisi; ma l'arte dei suoni poteva estendersi ampiamente in altre regioni: in un regno non facilmente raggiungibile.
Leggendo Platone e Kant si era convinto che nell'anima "come nel mondo fisico agiscono due forze entrambe ugualmente grandi, ugualmente semplici, desunte da uno stesso principio generale: la forza di attrazione e quella di repulsione." I filosofi, gli artisti, avevano dunque il compito di unire ciò che era diviso, di armonizzare ciò che sembra incompatibile. "La necessità della filosofia di ricondurre tutto ad un principio originario viene accentuata dalla musica. Un pensiero isolato ha pur sempre il senso della totalità in cui si esprime la sua affinità con lo spirito; così il pensiero musicale, nell'intima, inscindibile affinità con l'armonia universale è unità". "La legge morale in noi, ed il cielo stellato sopra di noi." La legge e l'unità anche della forma sonata, che nella sua idea guida - l'esposizione, lo sviluppo e la ripresa di due temi antitetici e complementari - descrive una divisione che diviene perfetta armonia.
Sin dalla prima giovinezza, Beethoven aveva desiderato aiutare e servire in qualsiasi modo, con la sua arte, la nostra coscienza divisa, "la nostra povera umanità sofferente"; in quel sentimento di intima felicità "che sempre accompagna tali azioni." Frequentando per qualche tempo l'università di Bonn, aveva appreso il pensiero di Kant e di Schiller, lievitandolo con le idee del nuovo illuminismo. La filosofia e l'arte, in questa inedita visione, non solo avevano il diritto ma il dovere di porsi come esempio, come guida, per trasformare la società: per mutare gli aristocratici privilegi feudali nella democratica visione della nascente borghesia. Poi, fu la scoperta dei grandi poeti: Omero, Shakespeare, Goethe, che con Platone rappresentarono la guida della sua vita. Nel 1809 scrisse agli editori Breitkopf e Haertel: "Non c'è trattato che possa risultare troppo dotto per me; anche senza la minima pretesa di possedere una vera e propria erudizione. Fin dall'infanzia mi sono sforzato di comprendere il pensiero degli uomini eletti e dei sapienti di ogni tempo. Sarebbe vergognoso che un artista non considerasse suo dovere arrivare almeno fino a questo punto."
Tuttavia il suo iniziale, caloroso idealismo si attenuò presto. A contatto col mondo e con una grande città come Vienna, gremita da una eccessiva presenza di persone il cui scopo principale si riduceva nel mangiare salsicce e bere birra scura, anche il suo entusiasmo dovette ridimensionarsi. Poteva il pensiero della musica educare, convertire tutti? Poteva la forza dei suoni far intuire una presenza spirituale ad un pubblico tanto superficiale? Al contrario, sembrava che le contemporanee opinioni sull'estetica e sulla morale fossero opposti al suo credo, e volessero con forza combatterlo. Mentre le sue opere - e di questo era ben cosciente - non potevano divenire popolari: non essendo certo scritte per la massa, ma per alcuni uomini solitari, come i nobili Kinsky, Lobkowitz e l'arciduca Rodolfo - fratello dell'Imperatore - che a partire dal 1809, almeno per qualche anno, gli garantirono un reddito fisso. Ma anche la maggior parte dell'aristocrazia e della borghesia sembrava troppo occupata nelle faccende politiche e commerciali per potersi dedicare alle cose dell'interiorità; e il cosiddetto popolo, l'indistinta plebe, si profilava nei suoi confronti in una distanza incolmabile. Insomma, l'uomo che non amava la musica e che non era commosso dall'armonia dei dolci suoni, l'uomo che era insensibile ai richiami di Orfeo, come gli insegnava Shakespeare, era un individuo difficile, nato "per il tradimento, per i raggiri e le rapine." Mentre i moti del suo spirito erano foschi come la notte, "ed i suoi appetiti oscuri come l'Erebo." Così, sempre più netta in lui si individuava l'idea di isolamento, la figura dell'eccezione, presto acuita drammaticamente dal problema della sordità.
Il 6 ottobre 1802, dal sobborgo viennese di Heiligenstadt, a quelle persone che erroneamente lo reputavano scontroso e misantropo, astioso e difficile, egli volle indirizzare un messaggio ricolmo di commozione: fin dall'infanzia, in realtà, il suo cuore ed il suo animo erano stati inclini "al delicato sentimento della benevolenza" nella naturale disposizione di compiere azioni generose. E soltanto a causa di una grave malattia, la sordità - i cui primi sintomi si fecero sentire già dal 1796, quando era appena un ragazzo di ventisei anni -, cominciò a chiudersi in se stesso. Da allora, di anno in anno, le sue speranze di guarigione erano andate gradualmente deluse, fino all'accettazione di una malattia cronica. "Pur essendo dotato di un temperamento ardente, vivace, e anzi sensibile alle attrattive della società", era stato presto obbligato ad appartarsi, ad isolarsi, trascorrendo la vita in solitudine. "Se talvolta ho deciso di non dare peso alla mia infermità, ahimè, con quanta crudeltà sono stato allora ricacciato indietro dalla triste, rinnovata esperienza della debolezza del mio udito. Tuttavia non mi riusciva di dire alla gente: "Parlate più forte, gridate: perché sono sordo". Come potevo, ahimè, confessare la debolezza di un senso, che nel mio io dovrebbe essere più raffinato che negli altri uomini e che in me un tempo raggiungeva un grado di perfezione massima, un grado tale che pochi nella mia professione sicuramente posseggono". Era una terribile sventura che lo faceva doppiamente soffrire, poiché sentiva di essere frainteso. L'isolamento, l'impossibilità organica non gli permettevano il dialogo, la conversazione, le dolci confidenze reciproche. Come un proscritto, un escluso, in società poteva accedervi furtivamente soltanto per le occasioni più impellenti o formali. Aveva da poco trascorso sei mesi in campagna, tra gli alberi, il colore del grano, il sogno delle nuvole, le cattedrali dei boschi, sentendo intorno a sé un silenzio religioso e magico. Ma, appena era stato sedotto dal desiderio di una compagnia umana, appena aveva tentato di comunicare con qualcuno, quale umiliazione! Mentre il suo compagno sentiva il suono di un flauto in lontananza, lui non sentiva niente; mentre l'altro ascoltava il canto di un pastore lui non udiva nulla! Tali esperienze lo portarono sull'orlo della disperazione, e soltanto l'arte, la sua musica, lo trattennero da un gesto inconsulto, salvandolo. Non era pensabile abbandonare questo mondo, senza prima dar sfogo al suo "imperioso bisogno di comporre". Bisognava, insomma, essere virtuosi ad ogni costo. Avere pazienza, molta pazienza. "Sopportazione, rassegnazione... così vinciamo anche quando siamo al sommo della miseria e ci rendiamo degni che Dio perdoni i nostri peccati." "Noi, creature finite con lo spirito infinito, siamo nate soltanto per soffrire e gioire e si potrebbe quasi dire che gli eletti ricevono la gioia attraverso il dolore". Operando ogni giorno per il bene, costruendo ogni minuto un'opera, un segno di amore e di pace.
Privato di quel senso, quell'organo che in lui avrebbe dovuto essere il più completo e perfetto; mutilato di quella facoltà che per la sua vocazione rappresentava il mezzo principale, Beethoven sentiva di aver subito un torto, una profonda ingiustizia. Dapprima aveva voluto lottare, battersi per una guarigione almeno parziale, e contro quel terribile destino che si prendeva gioco di lui. Più tardi, come gli aveva insegnato Plutarco, subentrò la rassegnazione, il distacco nella maturazione di una visione superiore: "Rassegnazione, rassegnazione profonda alla tua sorte - Questa soltanto ti permetterà di accettare i sacrifici che richiede il servizio e la lotta penosa." "Dio, Dio, mio rifugio, mio sostegno, tu che sei tutto per me, tu penetri la mia anima - Ascolta la mia preghiera, tu di cui io non saprò mai esprimere la grandezza, ascolta il tuo infelice Beethoven." Se Omero e Tiresia, i grandi scrutatori dei cuori e dell'esistenza, erano stati ciechi - erano stati costretti ad andare oltre i bagliori della superficie, al di là degli inganni delle apparenze - così anche lui era nobilitato a percepire quei suoni, quei colori invisibili, oltre il mondo dei fenomeni. E l'esempio della Grecia, fu sempre il suo modello ideale. Fin da ragazzo aveva letto in Platone che la musica poteva mutare le anime, trasformare i caratteri, forgiare i cuori. La poesia, cioè la parola alleata ai suoni, era azione, era coinvolgimento: volontà e capacità di fare. Era soprattutto la forma di un ethos, un carattere, una morale che riveste i diversi contenuti delle emozioni. Se questo mondo era soltanto "il migliore dei mondi possibili", guidato e rappresentato dal legno storto dell'umanità - un luogo che aveva perduto la scintilla divina, l'entità del sacro, ma non totalmente il suo rimpianto, la nostalgia verso quella perduta perfezione che si dilata in un richiamo nobile e struggente-; la filosofia, la musica, erano gli strumenti principali per una rieducazione, un riequilibrio delle forze a favore del cielo. Per questo amava intensamente il mito di Prometeo, l'eroe che aveva sottratto il fuoco agli dei per donarlo agli uomini; il racconto di una possibile libertà, di un miglioramento che non ha tempo. Il simbolo di un uomo straordinario come Napoleone che, prima di cadere nella vanità, aveva rappresentato la metamorfosi, il riscatto dell'umile che può diventare grande, del piccolo che può trasformarsi in solenne. La figura eroica di un carattere; l'occhio penetrante che scruta gli abissi della luce; lo sguardo dell'aquila che fissa la sfera del sole: il destino che contempla nella cognizione massima la "misura eterna".
Chi conobbe la persona Beethoven, fu colpito dal contrasto tra la sua musica, così alta, appassionata, assoluta, ed il suo modo di vivere: trasandato, bizzoso, trascurato. Entrare nella sua stanza, voleva dire penetrare in un luogo governato dal caos. Quando nel 1809 il barone Trémont gli fece visita, scrisse: "Immaginatevi il massimo della sporcizia e del disordine: pozze d'acqua che decoravano il pavimento, e un pianoforte a coda piuttosto vecchio sul quale la polvere si faceva spazio tra fogli di musica scritta o stampata. Sotto al pianoforte - non esagero - un vaso da notte non vuotato... La maggior parte delle seggiole impagliate erano coperte dagli abiti e dai piatti pieni degli avanzi della cena del giorno precedente." Posseduto dal demone dell'ispirazione, governato da una forza più alta, egli non aveva tempo per occuparsi delle faccende del reale. Tutto era subordinata alla composizione: al di là della musica ogni cosa poteva essere "importante senza importanza": molti uomini, nature sempre comuni, talvolta lo disturbavano nella loro incomprensione del non comune; i rapporti con le persone e il pubblico non avevano nulla di impellente; il pranzo o la cena dovevano attendere spesso lunghe ore prima di venir consumate, ormai fredde e talvolta immangiabili; le ore concesse al sonno erano appena rosicchiate al ritmo del lavoro; e le abluzioni consistevano anche in frequenti ed improvvise cascate d'acqua gelida versate sopra la testa da ampie bacinelle. Al suo fedele factotum, Schindler, egli sembrava "un fanciullo caduto sulla terra da qualche mondo ideale". Poteva essere dolcissimo, spiritoso, amabile, ricolmo di attenzioni e tenerezze; e ad un tratto - se toccato in qualche punto del suo delicatissimo io - trasformarsi in uno spirito sarcastico, ironico, offensivo: mutando il suo volto espressivo in una maschera severa e ghignante. Più spesso sembrava pervaso da una rude gentilezza. I primi anni, appena arrivato nella capitale austriaca, frequentando i salotti dell'aristocrazia come prodigioso improvvisatore al pianoforte, aveva dimostrato ottime maniere, gesti compassati, indossando abiti eleganti ed impeccabili. Poi, sempre più concentrato nella propria opera, era divenuto trasandato, non curandosi minimamente delle forme esteriori. Parlava ad alta voce - probabilmente un riflesso della sordità - gesticolava vivacemente, seduto a tavola stava terribilmente scomposto; al ristorante, talvolta ordinava una quantità enorme di piatti, per poi mangiarne soltanto pochi, vestiva abiti vecchi e sudici; ed era sovente polemico con tutte le forme di mediocrità: i cittadini di Vienna, la cattiva musica, le pessime governanti, e i molti amici che apparentemente lo trascuravano. Ma poteva essere molto comprensivo, e generoso: aiutando concretamente le stesse persone che poco prima aveva criticato con ferocia. A volte, aveva dei comportamenti strani. Con commozione, Grillparzer ricorda quando, durante una giornata trascorsa insieme, in una osteria, Beethoven lo invitò al tavolo, si assentò un istante, e tornato con cinque bottiglie di vino ne posò una davanti al piatto di Schindler, una davanti al suo, e tre le allineò davanti a lui, "probabilmente per significare, con quel suo modo di comportarsi ingenuamente rozzo e bonario," che il suo amico era libero di bere quanto volesse.
Poi, insieme presero posto nella carrozza; e gentilmente, invece di fermarsi al confine del suo circondario, Beethoven volle accompagnarlo sino alle porte della città. "Allorché vi giungemmo, mi strinse cordialmente la mano e scese, accingendosi ad affrontare da solo il lungo ritorno a casa, almeno un'ora e mezza di cammino. Mentre Beethoven scendeva dalla carrozza notai un foglio lì dov'era stato seduto. Credetti che l'avesse dimenticato e gli feci cenno di tornare per riprenderlo. Ma lui scosse la testa, ridendo sonoramente, come si può fare dopo uno scherzo riuscito, e si affrettò per la sua strada. Aprii il foglio e vi trovai l'esatta somma che avevo pattuito con il vetturino per il ritorno. Il suo modo di vita l'aveva a tal punto estraniato da tutti gli usi e costumi del mondo, che non gli passò neppure per la mente che in altre circostanze il suo comportamento sarebbe risultato offensivo. Quanto a me, accettai lo scherzo con un sorriso e pagai il vetturino con quel denaro avuto in dono."
Come scrisse lui stesso, tutto quello che faceva all'infuori della musica era fatto male ed era sciocco. Ogni cosa di cui si occupava al di fuori del suo assoluto magistero era approssimativo e incerto. Così i suoi rapporti con le donne: appassionati e paradossali. Da una parte, come testimoniano alcuni suoi intimi amici, era sempre innamorato: era sempre interessato a qualcuna, viveva avvolto nell'ideale, pensava ininterrottamente al sogno della famiglia, proiettando le forme dell'eros in un cielo di rarefatta beatitudine; dall'altra, per alcune ragioni, non riuscì mai ad avere una relazione normale. Da una parte, era ben conscio che la sua attività, la sua estrema concentrazione, non gli avrebbero permesso di calarsi nella parte di marito, di amante o di padre; e dedicarsi ad una donna, una famiglia, non avrebbe comportato la dispersione dell'"energia vitale"? Non avrebbe significato, forse, l'abbandono di quello che considerava essere qualcosa di più nobile e migliore? Dall'altra, innamorandosi sempre di donne socialmente più altolocate di lui, o molto più giovani, il rapporto era di fatto improponibile. Scrivendo la famosa lettera all'immortale amata - un testo straripante sogno e sapiente ingenuità - si era rivolto ad una figura anche simbolica: un angelo, un tutto, un Altro divenuto il proprio io. "Oh Dio, guarda la bella natura e acquieta il tuo animo su ciò che è inevitabile. L'amore esige tutto e con pieno diritto, così per me verso di te, come per te verso di me." Il tutto di una unione impossibile, e la certezza della separazione, del gesto severo dell'assenza, sempre in agguato per rovinare ogni cosa. Poiché, insieme, l'amore rende felici ed infelici, soddisfatti e anelanti, nel nobile progetto di essere eternamente insieme.
Così, quasi sempre il rapporto con l'altro sesso era un contatto virtuale, lontano, astratto. Era l'incontro di due coscienze, la fusione intima di un intimo, verecondo ideale. "Conserverò il tuo portafogli con altri segni di stima di alcune persone, ma la stima non è ancora meritata. / Continua, non limitarti a praticare l'arte, ma penetra nel suo cuore; essa lo merita, perché solo l'arte e il sapere innalzano l'uomo fino alla Divinità. Se tu, mia cara Emilia, dovessi un giorno avere un desiderio, scrivimi con fiducia. Il vero artista non è orgoglioso, purtroppo egli vede che l'arte non ha confini. Egli sente oscuramente quanto è lontano dalla meta e, mentre è forse ammirato dagli altri, soffre per non essere ancora giunto là dove il suo migliore intuito lo illumina soltanto come un lontanissimo sole."
In una luminosa giornata del luglio 1812, a Teplitz - una piccola località termale - Beethoven e Goethe si incontrarono. Da tempo il compositore della Nona sinfonia stimava e leggeva l'autore del Faust, col quale avrebbe volentieri discusso di quella poesia "che si innalza ad un ordine superiore come in virtù di spiriti e porta in sé il segreto dell'armonia": e di quella melodia che può divenire la vita sensibile delle parole e del contenuto spirituale di un testo. Entrambi erano grandi cultori della civiltà greca, che consideravano il luogo della perfetta unità. E Beethoven aveva sempre avuto per Goethe una stima profonda. La sua poesia era la forza, il canto, il vigore circonfuso di grazia. Era anche la straordinaria capacità di impossessarsi e manipolare le più disparate culture. Leggendo quel libro inesauribile che è il Divano occidentale-orientale, là dove "le parole dei poeti e le porte del Paradiso aleggiano e risuonano senza posa e sommessamente bussano invocando la vita eterna", aveva sottolineato tutti quei passi che sintetizzano la saggezza dei mistici persiani: "Il mondo assomiglia ad un fuoco acceso sulla strada; colui che ne prende quel tanto che gli occorre per farsi luce lungo la via non patirà nessun male, ma chi ne prende di più si scotta." Oppure, a proposito del grande Gialal ad-Din Rumi: "Di tutto egli si serve per trasmettere un misterioso insegnamento, di cui non sa egli stesso rendersi conto chiaramente. Istruzione ed edificazione sono il suo scopo e nell'insieme cerca, per mezzo della dottrina dell'unità, se non di saziare tutte le aspirazioni, almeno di distenderle nella speranza che alla fine tutto sarà immerso e trasfigurato nell'essere divino." Riconoscendosi nel commentatore e nel poeta - come un fratello. L'autore del Faust, che, come lui, considerava la fatica attraverso la lotta l'unico elemento in grado di redimerci, era ai suoi occhi un modello, un padre, capace di consigliarlo in ogni occasione. Tuttavia Goethe non ricambiava questo entusiasmo. Troppi suoni composti da Beethoven gli parevano eccessivamente drammatici, troppe dissonanze caratterizzavano i temi delle sue sonate. Certo, soprattutto nella musica esisteva l'inconscio, l'ispirazione, la tenebra; e la bellezza, la meravigliosa forma, risiedevano proprio nel controllo, nel dominio di queste tensioni notturne. Ma, se Mozart aveva brillantemente esorcizzato questi demoni - operando in quella capacità creatrice che agisce di suono in suono, di generazione in generazione - l'autore della Quinta sinfonia troppo spesso non poneva freno a quegli oscuri impulsi.
Dopo quel cordiale incontro, scrivendo a sua moglie, Goethe aveva riconosciuto di non aver mai visto "un artista più fortemente concentrato, più energico, più profondo"; pervaso tuttavia da "una personalità assolutamente sfrenata." Anche nel modo di suonare era talvolta delizioso, brillante; ma quasi sempre "poco delicato". Diversamente dai suoi contemporanei, come pianista, egli aveva un suono energico, robusto, a volte impulsivo; con uno staccato superbo, e una capacità di legato straordinaria, che modellava le più disparate melodie in una superficie di porosa luce. Poi, sapeva trascorrere con una velocità fulminea dal fortissimo più compatto al pianissimo più rarefatto, dal suono più drammatico alla melodia più fragile, sottolineando le asimmetrie ritmiche con violenti sforzando. Questo modo di suonare e di comporre così antropomorfico - sino alle soglie dell'ultimo periodo - questa inedita espressione tanto vicina al modo di essere e di sentire di ogni uomo - attraverso gli opposti del bene ed il male, dell'amore e dell'odio, del bagliore e della tenebra - non convincevano affatto Goethe. Per lui, che non amava gli eccessi del nascente romanticismo, l'arte era soprattutto controllo, ordine, classicità, in una forma levigata dal regolare scorrere dell'equilibrio: in una superficie scintillante che riflette l'immenso significato del mondo. Quelle forze caotiche, telluriche, che Beethoven non evitava, rappresentavano qualcosa di corrotto, di malato, perdendosi nei gesti di un apparente istrionismo. Tuttavia, la teoria del sublime aveva dimostrato che il senso dell'imponente, del solenne, dell'eroico, doveva avere qualcosa di violento, di terreno, di travolgente. "Per essere grande musica", una sinfonia, una sonata, dovevano possedere una quantità di melodie e di andamenti armonici anche apparentemente inconciliabili, ma che, sapientemente collegati in un tutto organico, raggiungevano le vette della bellezza. Dal caos, dalla confusione, nasceva un ordine; dalla tenebra, dal pauroso si distillava un'essenza insieme drammatica e dolcissima, ed il pensiero del sublime si profilava come qualcosa di giusto "che da tutto il disordine apparente del mondo fisico e di quello morale" faceva nascere "il più bell'ordine del tutto."
Anche l'autore della Missa Solemnis, era persuaso che la forma dell'opera ultimata dovesse contenere in sé le tracce della lotta, i segni della battaglia, per l'ispirazione contro la menzogna: per lo straordinario contro la mediocrità. Vi erano stati artisti e compositori, prima di lui, che trasfiguravano ogni contrasto cancellandone i riferimenti in un'aura di serenità e di pace. Erano i Mozart, i Bach, gli Haendel, che pur cantando, talvolta, le cose di questo mondo, le risolvevano nella loro mente senza rifletterne con eccessivo vigore i turgori nello specchio dei suoni. Erano autori che scrivevano con molta facilità, con pochissime correzioni, guidati da un istinto felice: da un fluido ininterrotto che si trasformava in note immacolate, che cadevano come neve dal regno dei cieli. Viceversa, il suo modo di scrivere era profondamente drammatico. Era una incessante lotta, un travaglio, un costante valutare e scartare, incorporare ed eliminare, accogliere ed espungere, che a fatica trovava un fermo equilibrio. "Le mie idee le porto a lungo dentro di me, spesso molto a lungo, prima di metterle per iscritto. E la memoria mi è tanto fedele che sono sicuro di non dimenticare, anche per anni, un tema una volta che l'ho concepito. Cambio molto, scarto e tento sempre di nuovo finché non sono soddisfatto, poi comincio a elaborare nella mia testa, allargo, restringo, spingo verso l'acuto e verso il grave e, poiché so cosa voglio, la concezione di fondo non mi abbandona mai. Questa si sviluppa, cresce, mentre odo e vedo in spirito il quadro, come di getto, in tutta la sua estensione e mi rimane solo il compito di mettere per iscritto; lavoro che procede rapidamente, a seconda del tempo che ho a disposizione, perché a volte mi dedico a più cose contemporaneamente, ma sono sicuro di non confondere l'una con l'altra." Sempre con il suo taccuino in mano - un prezioso ed ermetico scrigno in cui nessuno poteva rubare - passeggiando nei boschi, sperduto tra le mucche nei campi, sdraiato su di un prato, seduto al tavolo di una osteria: gesticolando come una felice marionetta, battendo i piedi come un bambino, sventolando le dita come ritmiche ali di farfalla, egli captava i segnali dello Spirito - così ricchi, così strani, così magicamente solenni - trasformandoli in parole simboliche, in crittogrammi araldici, in ghirlande d'aria.
A partire dal 1802, aveva avuto l'intuizione di una diversa via: un inedito stile compositivo. Aveva scritto due serie di variazioni, la prima di otto la seconda di trenta; ambedue erano lavorate "in una maniera interamente nuova", e strutturate ciascuna "in modo diverso". In genere erano gli altri che gli dicevano quando aveva avuto idee particolari, soluzioni originali, mentre raramente il suo spirito ne era cosciente. Ma, questa volta era lui a comunicare al suo pubblico "che la maniera in questi due lavori" era inedita e completamente sua. Studiando i compositori del passato, si era accorto della loro grandezza, dell'utilissimo magistero soprattutto di Haendel e Bach, che attraverso i percorsi difficili dell'arte, nel "grande creato", sapevano indicare le mete principale della libertà e del progresso. Poiché lo scopo dell'artista era quello di andare sempre avanti - anche se il nuovo e l'originale si manifestano sempre da sé, senza pensarci - e quanto maggiori erano i nuovi risultati, tanto meno ci si accontentava dei propri antichi lavori.
Prima di allora, più o meno fedele alla forma sonata, aveva scritto pensando a temi ben contrapposti, ad una dualità den definita e a blocchi sonori particolarmente delineati, che dialogano vivacemente attraverso contrasti caravaggeschi di ombra e luce, solarità e tenebra. Da quel momento, invece, optò per una forma più malleabile e aperta, libera ed empirica, che compendia in sé, a volte, più generi contemporaneamente: la sonata, la variazione, il rondò, la fuga, inventando per ogni composizione una imprevedibile "configurazione tematica" che si articola in una brillante "ambiguità formale". A partire dalle due splendide Variazioni per pianoforte op.34 e op.35, dimostrò così che questo genere in quel tempo superficiale, e decaduto a semplice gestualità di un virtuosismo vuoto e spettacolare, nascondeva in sé inesauribili possibilità: nel concatenamento sottile e recondito dell'idea tematica, nel riverbero delle relazioni tra armonia e melodia, canto e accompagnamento, nella funzione generatrice degli spazi intervallari che si sviluppano in un intarsio di rara coerenza, nell'idea centrale di invenzione, come diversità, molteplicità che ruota incessantemente intorno ad un perno presente e virtuale. Se con opere come la Sonata in do minore - la cosiddetta Patetica - la Terza Sinfonia e i tre Quartetti dedicati a Rasumowsky - tutte risalenti intorno a quegli anni - aveva approfondito le possibilità del contrasto, le sfumature dell'ombra, le tensioni del diverso - nell'idea centrale del patetico schellinghiano come capacità di ordinamento e sintesi, unione e armonizzazione -; dai primi anni dell'Ottocento cominciò a modellare le sue contrapposizioni in una pasta più articolata e sottile, più discreta e raffinata, che si perfeziona negli ultimi anni.
Così, quando ascoltiamo le sue ultime composizioni, siamo colpiti ogni volta da una straordinaria intensità. Un gioco di suoni che disegna una circonferenza atemporale. Una sfera di luce che si riverbera in un bagliore sidereo. Una giostra di timbri come stelle e galassie, nel cielo del tempo. Uno spazio assoluto dove anche il segno grafico della scrittura è mutato, è più elegante, è meno corposo, è più leggero, con quei gambi ben delineati e quei tagli delle brevissime note, veloci e intensi, che talvolta, a partire dalle Sonate per violoncello op.102 e dalla Sonata op.101 - composta proprio in quel 1816, anno inaugurale della sua completa, metafisica sordità - ricordano una grafia orientale. Note scritte, che fanno pensare direttamente a qualcosa che "pare abbia superato i confini di ciò che è terreno o corporeo .... come se i pensieri e le visioni del compositore appartenessero ad un altro mondo", proiettandosi in un universo sconfinato. Note talvolta appena percepibili, dove ascoltiamo forme aperte che dialogano con l'infinito (Sonata op.111, Grossa Fuga op.133); frammenti apparentemente liberi che si ordinano su di un castone presente e invisibile (Nona Sinfonia; Variazioni Diabelli op.126, tutti gli ultimi Quartetti); melodie dilatate in arabeschi armonici (Sonate opp.109 e 110); soluzioni modali e riferimenti antichi (Missa Solemnis, terzo tempo del Quartetto op.132); lievi ragnatele di contrappunto in cui la rugiada dell'armonia si illumina di bagliori melodici in perle argentate (fughe e polifonie delle opp. 109, 110, 132, 133, 135) melodie accordali rarefatte e lentissime (ventunesima variazione delle Variazioni Diabelli); trilli statici che si perdono in prospettive infinite (Sonate op.106, op109 e op.111); un canto dolcissimo in cui Schumann e Chopin s'incontrano in una icona impossibile e reale (trentaduesima variazione Diabelli). Il tutto, sempre nella inedita congiunzione del grandioso con l'umile, dell'eroico con il dimesso, del solenne con l'introspettivo: dove timbriche fosforescenze alla Grunewald dialogano con rarefatte atmosfere rembrandtiane.
Il 9 gennaio 1816 - ad un anno dall'ultimo decennio della sua vita terrena - Beethoven vinse la causa per la tutela esclusiva del nipote Karl, il figlio omonimo di suo fratello - da pochi mesi scomparso. Con forza, con determinazione, lo aveva strappato alle grinfie della madre: una donna dai facili costumi: "Questa Regina della Notte è stata sino alle tre del mattino al ballo degli artisti, esibendosi non solo nella nudità del cervello ma anche in quella del corpo. Si sussurrava che si poteva avere per venti fiorini! Orrore. Possiamo affidare a queste mani, anche per un solo istante, il nostro prezioso tesoro? No, certamente no." Aveva lottato con vigore per averlo, perché l'artista, come gli insegnava Schiller, non può soltanto volere o dominare o servire, ma deve "educare, nient'altro che educare". Ma aveva compiuto davvero il suo dovere, o si era comportato come un tiranno? Non aveva offeso il cuore, pur cristiano, di quella povera vedova? Rivolgendosi con intimità al Signore, a Dio onnipotente, sentiva di avere agito secondo il meglio, trascurando spesso il suo stesso bene. "Dio, Dio, mio rifugio, mia rocca o mio tutto. Tu vedi nel più profondo del mio cuore e sai quanto mi addolori il dover far soffrire qualcuno con la mia buona opera per il mio Karl!! O, ascoltami, sempre Ineffabile, ascolta il tuo infelice, il più infelice di tutti i mortali!" Così distante dalla vita, così lontano dalle cose di questo mondo, senza accorgersene, stava proiettando sul proprio nipote un eccesso di premure e attenzioni che avrebbero esasperato qualsiasi individuo. Deluso dall'amore, ormai rinunciatario al sogno della famiglia, stava riversando su di un semplice giovane un cumulo di ideali frustrati, che rischiarono di seppellirlo. Si sentiva chiamato ad infiammarlo con il proprio esempio "alla virtù e al lavoro". Come Filippo il Macedone aveva condotto direttamente l'educazione del figlio Alessandro, così lui avrebbe forgiato l'animo di suo nipote. Non più soltanto sulla materia sonora, ma anche nel corpo vivo di una coscienza, avrebbe modellato la forma della perfezione. Come gli avevano insegnato i greci e Platone, il progetto dell'uomo doveva misurarsi anche in questo mondo, doveva provarsi attraverso le nostre entità imperfette, nella prospettiva pedagogica di una mente sana in un corpo sano: per vederlo virtuoso negli studi - quale entusiasmo sapere che stava imparando il greco! - virtuoso nell'amore, virtuoso nella vita. Ma, se manipolare i suoni, attraverso la dura lotta del lavoro e dell'ispirazione, trovava sempre un esito positivo; se comporre musica, lungo il travaglio di un difficile percorso, conduceva sempre ad una meta piacevole e a soluzioni migliori, molto diverso era indirizzare lo stesso ideale nelle ambiguità dell'uomo, di un ragazzo, pervaso, come tutti, dal bene e dal male, da vizi e virtù. Il 30 luglio 1926, soffocato da smisurate attenzioni, Karl tentò il suicidio. Eccessivamente tormentato dallo zio, aveva inscenato o autenticamente compiuto quel gesto radicale. Per fortuna la ferita fu curabile. Più tardi, quando il magistrato che condusse le indagini lo interrogò, egli rispose: "sono diventato peggiore perché lo zio mi voleva migliore".
Ciò che riusciva splendidamente con i suoni, ancora una volta era andato drammaticamente deluso con le forze del mondo. Oltre la sua arte, un altro rapporto con l'uomo - il più caro e ambizioso - era fallito miseramente. Durante gli ultimi anni, con maggiore concretezza egli sentiva che una sorte ben dura lo aveva colpito. La rassegnazione al destino e la preghiera a Dio rimanevano gli unici balsami per quella ferita inguaribile. Era come sopportare una morte vivente, dove i termini del bello e del brutto, del bene e del male, si mescolano in un turbine feroce. Nello spazio della modernità, nel luogo deputato del mondo civile, la città, attraverso le sue infelici esperienze, sembrava così che tutti i valori si perdessero in non valori, che ogni cosa si confondesse con troppe cose, e ogni entità si smarrisse in un turbine di falsità e apparenze; mentre il sogno dello spirito si frantumava nelle chiacchiere della menzogna. Anche per questo, mai soddisfatto delle proprie abitazioni, Beethoven cambiava alloggio continuamente. Irrequieto, cercava il luogo ideale: in un podere rustico, dove sarebbe sfuggito alla sua miseria; in una capanna remota, nascosta tra le fronde degli alberi; in una piccola casa, ma così piccola che sarebbe stata capace di ospitare soltanto un uomo! O in una dimora alle porte di Vienna, a destra verso la montagna, con la posizione verso il mattino, le aurore, i primi fuochi dell'aria, ed il cielo incendiato dalle fiamme delle nuvole. Soprattutto in campagna, era come se ogni albero gli facesse intendere la voce del Divino, e gli dicesse: "Santo Santo! Incanto nella foresta! Chi può esprimere tutto questo?" I boschi, gli alberi, le rocce: i fiori, l'acqua, le pietre, i ruscelli, gli davano l'essenza di quella eco che "l'uomo brama di intendere". "Quale splendore, Signore. Queste foreste, queste valli respirano la calma, la pace che occorre per servirTi." "Da quanto ci è dato di scorgere nelle sue opere, possiamo conchiudere che Egli è eterno, onnipotente, onniscente, e onnipresente...Oh Dio, Tu sei la luce vera, beata, eterna, di tutti i tempi e di tutti i luoghi. La Tua saggezza riconosce mille e più che mille leggi, mentre Tu agisci sempre liberamente e a Tuo onore... A Te le nostre lodi, a Te la nostra adorazione. Tu solo sei il vero Beato (Bhagavan); Tu l'essere di tutte le leggi, l'immagine di ogni sapienza".
Specchio del Divino, così la natura era "una scuola gloriosa per il cuore!" E lui, con animo semplice e ardente, sarebbe stato un riconoscente allievo. Da questa forza nobile e misteriosa, avrebbe imparato la saggezza, la vera conoscenza di Dio per le delizie celesti. Con umiltà, si sarebbe assoggettato totalmente ai casi e ai mutamenti della vita, per affidarsi alla Sua incomparabile bontà. Lontano dalla vita sociale, lontano dai paradossi antropomorfici, nella natura il suo animo trovava pace. Che serenità si respirava in quella sinfonia di forme, in quel concerto di strumenti silenziosi che solo raramente si distinguevano in suoni ineffabili! Che gioia era trasmettere le sensazioni di quei colori, l'espressione di quei profumi: il manto dei prati screziato dalle modulazioni dei fiori, l'aroma delle mille sfumature del cielo attraverso le vetrate dei rami che trasformavano le immagini fantasiose dei santi in un mare di cobalto; e ritmavano l'azzurro nella gamma composita dei verdi e dei grigi! Senza scadere in banali descrizioni, Beethoven ne sapeva rivelare il segreto in una pittura invisibile. "Più grande il ruscello, più profondo il suono"; il sibilo della tempesta; il crepitio sottile della luce, la spuma delle foglie mosse dal vento: le voci degli uccelli: il flauto che ricorda il trillo dell'usignolo; il clarinetto che imita il verso del cuculo, "l'oboe il grido acuto della quaglia": nella magia senza tempo della Sinfonia Pastorale.
Il 6 marzo 1825, giorno della vigilia della prima esecuzione del Quartetto op.127 - il primo dell'ultima serie - "come un generale prima della battaglia", Beethoven scrisse agli interpreti: "Miei bravi! Ciascuno farà quanto può e compirà il proprio dovere e ciascuno si impegna, sull'onore, di comportarsi nel modo migliore. Ciascuno di coloro che partecipano a quanto convenuto deve sottoscrivere questo foglio." Ma com'era difficile questa musica! Com'era nuova e complessa! Vi era una originalità troppo sottile da afferrare. Vi era qualcosa che andava oltre alle comprensione di qualsiasi individuo del XIX secolo. A Grillparzer, quegli estremi confini che disegnano le sue ultime opere erano apparsi come dirupi incombenti e minacciosi, come le vertigini paesaggistiche di Friedrich, enigmatiche e infinite, meticolose e visionarie. Forme, colori, rivelazioni, musiche, per loro, del tutto incomprensibili. Quell'uomo poteva fare tutto: poteva concepire dei suoni, puramente metafisici, astratti - ormai lontani dalle prime eroiche tensioni - che avrebbero scavalcato l'intero Ottocento. Poteva pensare una musica assoluta che solo per esigenze storiografiche ha una collocazione cronologica. A qualcuno, era apparso come una presenza incommensurabile, come lo Shakespeare dell'arte immateriale, che dopo aver capito tutto sapeva rappresentare e comunicare tutto. Un uomo, permeato di tensioni insieme equilibrate ed enormi, eleganti ed impetuose, ben conscio che ogni valore capace di toccare il cuore viene dall'alto, per esprimere i segni del cielo: "Credete voi che io pensi al vostro misero violino quando lo spirito mi parla?" "La mia sostanza è senza sostanza". "Il mio regno è nell'aria. Come spesso fa il vento, così i suoni turbinano intorno a me, così tutto turbina intorno alla mia anima."
Due anni dopo, mentre lo spirito continuava a suggerirgli forme quasi inafferrabili, e una finalità infinita lo conduceva nei luoghi di un mistica astrazione, si avvicinarono gli ultimi giorni. Il 3 dicembre 1827 era costretto a letto dall'idropisia. Da circa tre mesi non aveva potuto più scrivere una nota. Si sentiva stanco, sconfitto. Gli era penoso vivere; e percepiva che l'esistenza gli sarebbe stata intollerabile senza una meta, "uno scopo più alto". Si sentiva ferito e spezzato in ogni punto della sua persona. Era così debole che a fatica provava a reggersi in piedi. Mentre attraverso una continua solitudine intravedeva l'uomo dalla falce, che non avrebbe tardato molto. Di notte, forse rimpiangeva di non poter più contemplare con lo sguardo o con gli schermi astronomici trasparenti che aveva ordinato, quei corpi luminosi chiamati soli e terre, stelle e pianeti, gravitanti eternamente lassù, dove tutto era stato creato. Avrebbe voluto subito volare ad ali spiegate nell'aria sul Pegaso; avrebbe volentieri trasfigurato il suo povero corpo in una entità invisibile. Ma, lo sviluppo e la fine della malattia erano imprevedibili. E senza comporre aveva paura di perdere quel minimo necessario di sostentamento per sé ed il nipote Karl. Aveva il volto di fuoco, spesso sputava sangue, l'intestino ed il fegato lo tormentavano; mentre "il respiro minacciava di soffocarlo e una terribile fitta al fianco lo costringeva a una dolorosa posizione supina." Poi le cose andarono peggiorando, quando i primi attacchi di itterizia, dovuti anche ad una collera violenta provocata dall'ingratitudine e dall'"immeritata umiliazione", lo facevano contorcere e tremare. Tuttavia - come Socrate sull'orlo della morte, calmo e ricolmo di saggezza - credeva ancora nella vita, nell'uomo, nella speranza che la Società Filarmonica di Londra, come promesso, organizzasse un concerto a suo favore. Per questo aveva in mente ancora molte composizioni: un Requiem, un oratorio, un'opera, la Decima Sinfonia. "Ancora una sinfonia, poi partire, partire, partire." Sentiva di avere una sola via per salvarsi, andarsene. Soltanto così avrebbe potuto innalzarsi ancora una volta alle vette dell'arte, invece di sprofondare nella mediocrità. E perché restarsene in quel luogo, "quando ogni sovrano straniero sarebbe stato pronto a dargli un posto accanto al suo trono?". Dopo averlo abbandonato, come un essere inutile, sembrava che l'intera civiltà tedesca non ne volesse più sapere di lui e delle sue opere. Tutto a Vienna era divenuto "gretto e meschino"; tutti gli parevano dei farabutti, di nessuno ci si poteva fidare; e da quando si eseguivano gli ultimi melodrammi di Rossini, anche il gusto del pubblico si era enormemente abbassato: nella facilità, nella banalità, in un mondo senza tensioni, completamente in superficie. Anche per questo, l'Inghilterra ai suoi occhi era qualcosa di magico. Era il luogo della cultura, della civiltà, delle autentiche passioni, della grazia. Era la sua vera patria, la nazione dalla quale aveva ricevuto in omaggio i quaranta volumi dell'opera completa di Haendel, il suo compositore preferito, che sfogliava e risfogliava con l'entusiasmo e la gioia di un bambino. Era il luogo ideale dove ciascuno svolgeva seriamente il proprio compito, e tutti sapevano qualcosa e lo sapevano bene.
Le uniche consolazioni, in questi ultimi mesi, erano le rare visite di alcuni rari amici, e la presenza discreta e leggerissima di Gerhard von Breuning: il giovane figlio di una famiglia che gli era stata sempre vicino. Il suo sorriso candido, la sua figura innocente, i suoi gesti premurosi - fedeli e intimi come il "bottone dei pantaloni", secondo una curiosa definizione di Beethoven stesso - avevano il potere di rasserenarlo, di rincuorarlo; in mezzo a quel periodo di acute sofferenze, quando nel solo mese di febbraio aveva dovuto subire due operazioni. Anche a quel fanciullo, "lieve come il vento", la malattia sembrava lunga, difficile; ma presto guaribile, quando al principio della buona stagione sarebbe sfumata al contatto con la dolce natura e il balsamo del tempo. Intanto, che cosa desiderava leggere il suo forte paziente? ancora un romanzo di Walter Scott, la Storia Universale di Schrockh, le Descrizioni di viaggio di Sommer o le opere di Omero e Shakespeare che già conosceva come le sue partiture? O era meglio riposare ancora, cercando di scacciare quelle fastidiose cimici che disturbavano il suo sonno? Gli ultimi giorni, verso la fine di marzo del 1827, era così debole che non poteva nemmeno più scrivere, non poteva più comunicare con nessuno, chiuso nel suo doloroso silenzio - come un suono sperduto nella vertigine dello spazio. E mentre il suo Ariel fluttuava tra le sue stanze - libero e innocente come uno spirito - mentre la sua preghiera con maggior tenerezza si rivolgeva all'unico Dio, e il senso di una cristiana rassegnazione aveva raggiunto, attraverso la dura navigazione del sacrificio, il porto del suo cuore, come Prospero nel finale della Tempesta, tra pochi istanti anche lui avrebbe abbandonato un'invincibile magia, avrebbe sciolto le ghirlande dell'incantesimo, per consegnarsi agli uomini e all'eternità con le proprie nude mani, evocando la vittoria della rinuncia: "O voi, elfi dei colli, dei ruscelli, e dei laghi tranquilli e delle selve; e voi, che lungo le sabbie, con piede che non lascia orma, inseguite Nettuno quando arretra strisciando dalla riva, e lo fuggite quando torna; o voi piccoli gnomi che al lume di luna fate cerchi d'erba aspra che la pecora non bruca, che per gioco fate nascere i funghi di mezzanotte e con gioia udite il grave coprifuoco; voi, mie deboli potenze: col vostro aiuto ho oscurato il sole a mezzogiorno, suscitato i venti impetuosi, ho sollevato il verde mare in furia contro la volta azzurra, dato fuoco al tremendo e strepitoso tuono, ho spaccato la quercia di Giove con il suo stesso fulmine, scosso dalla dura base il promontorio, sradicato il pino ed il cedro. Con la mia arte potente, al mio comando, le tombe svegliarono i morti, si aprirono per liberarli. Rinnego, ora, la barbara magia e quando avrò chiesto, come qui chiedo, un'armonia celeste che con aereo incanto agisca sui loro sensi - era questo l'intento - spezzerò la mia verga e la metterò giù molte tese sotto terra, e là, dentro il mare, dove non giunge lo scandaglio, affonderò il mio libro."
Paolo Repetto