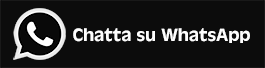Mahler: l'inganno della vita
Mahler scriveva volentieri per la voce: era il mezzo ideale per far risuonare il suo pessimismo viscerale. Il suo strumento, però, era l'orchestra, l'orchestra che conosceva bene come direttore, l'orchestra che gli metteva a disposizione la tavolozza timbrica necessaria a dipingere i suoi mondi così colorati.
Scrivere Lieder con orchestra, per lui, era stato naturale, quasi ovvio, ed ereditare da Beethoven una voce che canta in una sinfonia, portare avanti il lascito della Nona, gli aveva persino regalato un orizzonte storico di riferimento. Non c'era bisogno di stare troppo a spiegare, era ormai lecito accompagnare un cantante con una grande orchestra - come capita nei Kindertotenlieder o nei Lieder aus "Des knaben Wunderhorn" - ed era lecito inserire voci nelle sinfonie - capita dalla Seconda in poi. Tanto lecito che, ormai, la differenza tra i due generi si assottigliava opera dopo opera.
Così, quando si trova sul leggio Das Lied von der Erde, Mahler esita: se lo assegna al genere "sinfonia" gli tocca dargli il numero nove, nove come la Nona, nove come l'ultima sinfonia possibile perché guai a superare gli esiti aritmetici di Ludwig van (poi lo farà, arriverà a un pezzo di Decima, e vabbè); se ne fa un ciclo di Lieder, invece, risparmia una cartuccia sinfonica ma perde quel certo respiro, sostanzialmente psicologico, che siamo abituati ad aspettarci dai nipotini di Beethoven. Così lo intitola Il canto della terra e lo sottotitola Sinfonia per tenore, contralto (o baritono) e orchestra, cercando di salvare capra e cavoli.
D'altra parte questa volta Mahler aveva bisogno di tutto il fiato possibile: Das Lied von der Erde era la partitura con la quale esorcizzare, cantandole, le tre sventure che gli erano piombate addosso nel 1907. Nel giro di pochi mesi era stato costretto a dimettersi da direttore dell'Opera di Vienna, gli era morta la figlia primogenita e gli avevano diagnosticato una grave disfunzione cardiaca. Quando, alla fine dell'estate, il suo amico Pollak va a trovarlo, il povero Gustav è ancora sotto shock; eppure riesce a trovare le energie per rendersi conto che il libro e il suggerimento che gli vengono offerti sono preziosi: una raccolta di ottantatre antiche poesie cinesi tradotte in tedesco e l'idea di metterle in musica. È quello che ci vuole: sono meditazioni sulla vita e sulla morte congeniali alla sua attuale condizione psicologica e, dopo la sua prima stagione di impegni americani, nell'estate del 1908 si sistema a Dobbiaco, sulle Dolomiti, e comincia a scrivere.
Scrive la sua musica, che si muove sulla falsariga delle forme di tradizione e dunque nel primo e nell'ultimo Lied ostenta esposizioni, sviluppi e riprese, al secondo posto inserisce un movimento moderato e sceglie tre intermezzi a fungere da scherzo prima di arrivare al finale. E scrive un finale importante, come lui ama che sia, e infatti tutto l'arco drammaturgico è teso verso l'ultimo Lied, che da solo dura come tutti gli altri messi insieme. Scrive per una grande orchestra, una di quelle che gli piaceva schierare, ma non la fa quasi mai suonare tutta insieme, non cerca l'effetto di esuberanza sonora che potrebbe facilmente ricavare da tutti quegli strumenti raccolti davanti a sé: no, qui Mahler scandisce l'orchestra in tanti gruppi da camera e li utilizza a rotazione, uno alla volta, in un contrappunto lineare, leggero, che Schoenberg coglierà al volo perché poi, nel corso del secolo, piacerà molto questa idea di tenere a bada il motore sinfonico. E scrive, naturalmente, le note del proprio dolore, dell'inganno che è la vita, della nullità di ogni cosa, della solitudine dell'uomo che trova un possibile significato soltanto nel ciclo eterno della natura senza per questo riuscire a consolarsi (e come farlo?). Il risultato, si sa, è un capolavoro.
Nicola Campogrande (da www.sistemamusica.it)