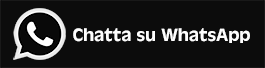Nel silenzio di Beckett
Basta in verità aver presente l'Ecclesiaste per sapere di che cosa tratti il teatro di Samuel Beckett.
Eccoci qui, tra l'urlo della nascita e il rantolo della morte, a raccattare e lasciar ricadere a manciate la cenere che tappezza questa valle di lacrime e vanità.
Starsene immobili, in silenzio assoluto, sarebbe l'atteggiamento più saggio e decoroso, data la situazione; ma si sa, le povere larve non sono qui per scelta ascetica, non sono all'altezza di tanto rigore, e allora dicono, chiacchierano, balbettano, scherzano, ricordano, fingono dispute, speranze, rancori, aggregano sillabe ora banali, ora insensate, ora casualmente sublimi.
La parola, nei primi momenti del soggiorno, ha ancora la funzione, sia pure decrescente, contestata, di arrodare un po' di deserto. Qualsiasi pretesto è buono per improvvisare la recita della vita, un topo, un albero, una scarpa, una formica, una banana, preziosi relitti lungo la monotona battigia del nulla.
I naufraghi sono in quest'arte più ingegnosi di Robinson Crusoe, sanno spremere da quel minimo un massimo di sopravvivenza duttile, fantasiosa, interessante, addirittura teatrale. Talvolta farneticano, talvolta scivolano nella pagliacciata grottesca, o si abbandonano al più abbietto sentimentalismo; o ancora, eccoli tronfi retori, crudelissimi tiranni, e poi subito gongolanti inventori di giochi di parole, fornitori di barzellette infime, maestri di cinismo, sarcasmo, versatori di lacrime viscerali o grossolanamente fittizie.
Nessuno di loro può mai scordarsi del suo stato. Al contrario dei personaggi di Pirandello, che al teatro ancora aspirano come a un luogo privilegiato grazie al quale avranno infine il diritto di narrare la propria storia e dunque di esistere, questi di Beckett sanno di essere in scena, dantescamente, da sempre e per sempre, poveri attori nel senso codificato da Macbeth, che dopo il loro breve numero spariranno inghiottiti dall'oblio.
Tutti si portano dietro un passato confuso e opprimente come un sacco da pellegrino, da clochard, tutti provengono per così dire dalla diaspora del "vecchierel bianco, infermo, mezzo vestito e scalzo, con gravissimo fascio in su le spalle" descritto nella sua futile corsa da Leopardi.
Abbondano malattie, menomazioni, paralisi, piaghe, il cui ovvio valore allegorico è brutalmente compromesso da un realismo ancora dantesco e dal quale Beckett, come Dante, non teme di trarre effetti di elementare e feroce comicità.
Costretti a una vita bassa, spicciola, subita, o meglio, strisciata a fatica minuto per minuto, i dannati hanno tuttavia repentini soprassalti verso l'alto. È la memoria, di solito, a provocarli con le sue lingue di fuoco: la vendemmia nel Vaucluse, un bacio in un capanno, un nome di donna, una barca dondolante sul fiume, un verso di Baudelaire o di Keats, bastano a infilare nel loro chioccio balbettio un'inflessione tutto a un tratto ispirata, un anelito lirico.
Ma sono attimi: la rievocazione, quanto più è commossa, struggente, o magari orgogliosa, tanto meno regge allo scherno contestuale. C'è poco da sognare, da rimpiangere, c'è poco da illudersi. Lo slancio del volenteroso verme è presto stroncato da lui stesso o dai suoi complici di sventura, tutti ben coscienti dell'"inganno consueto", tutti uomini che, come Montale, si sono voltati, hanno visto "compirsi il miracolo": il nulla alle loro spalle, da cui ogni evasione è impossibile.
Beckett è dunque un poeta tragico, animale clamorosamente incongruo in un mondo dove sono venuti meno i miti, gli eroi, gli dei, i fiammeggianti dilemmi, le colpe immani della tragedia classica. Nella nostra terra desolata e degradata Dio stesso è ridotto a un numero da rivenditore d'auto di banlieue, Monsieur Godot, o può al massimo incarnarsi in un campanello che scandisce, invisibile, le nostre giornate o irride ai nostri conati. È Agamennone è un re degli scacchi inchiodato su una sedia a rotelle o impegnato in un finale di partita ripetibile all'infinito. Nessuna conclusione, nessuna catarsi è più possibile per queste vicende senza sviluppo, di cui ci vengono mostrati segmenti ricominciati nei secoli dei secoli.
Tutti i personaggi seguono un unico vettore, verso l'afasia. Non ingannino i garruli mendichi Vladimiro o Estragone, il pomposo descrittore di tramonti Pozzo, il farneticante Lucky, la logorroica Winnie di Giorni felici, gl'impietosi e instancabili antagonisti di Finale di partita, l'amabile, pettegola Mrs Rooney di Tutti quelli che cadono. Sotto la volubilità quasi "mondana" di questi conversatori di maniera (magistrale campionario, en passant, di teatro "leggero"), le voci si vanno affievolendo, le parole precipitano nell'imbuto dell'irrilevanza. "È così che sarà l'inferno, - riassume l'Henry di Ceneri - lunghe chiacchierate al mormorio del Lete rievocando i bei tempi andati, quando ci si augurava di morire presto. [pausa] Il prezzo della margarina cinquant'anni fa".
Krapp già parla (a se stesso) mediante vecchie registrazioni. La Bocca di Non io è muta: quando scopre di poter parlare, che cosa sia la parola, ne è terrorizzata. E nei brevi testi che si susseguono d'anno in anno, l'afasia guadagna inesorabilmente terreno.
Quando esperimenta col cinema, Beckett (in Film) sceglie come protagonista un famoso attore del muto, Buster Keaton (all'epoca però - 1964 - caduto in dimenticanza), e non gli fa pronunciare una sola parola. Quanto ai simboli di Atti senza parole sono, appunto, senza parole, e senza parole finiscono del resto per essere tutti: se ne stanno lì, al centro o in un angolo della scena, impietriti o quasi, e qualcuno, una voce fuori campo, un testimone occasionale, un altoparlante che ne amplifica i sospiri, tenta di ricostruire la loro remota e incoerente storia.
È una sorta di distillazione sempre più avara e al tempo stesso sempre più ricca di suggestioni, risonanze, echi dolenti e dolcissimi come colti dalle labbra di un morente.
Negli ultimi anni, quando il suo editore o il suo agente annunciavano l'arrivo di un nuovo testo di Beckett, era lecito aspettarsi una busta con un foglio bianco, se non vuota. Ma le poche parole che poi effettivamente si trovavano nel magro dattiloscritto avevano un peso aureo, una densità via via più arcana e intraducibile.
L'intraducibilità di Beckett non è subito evidente, poiché egli usa parole comunissime e una sintassi ormai al di là di ogni sperimentalismo. Il traduttore se ne crede padrone - gli equivalenti sono tutti lì, pronti per essere trasposti - e si mette spensieratamente all'opera. Ma una sottile scontentezza comincia a roderlo: la situazione è semplice, il plot, se così lo si può chiamare, è chiaro, i dialoghi non hanno nulla d'indecifrabile. Ma il risultato della traduzione sembra un po' piatto. Si vanno a controllare certe interiezioni, le sfumature di un'ingiuria, un hélas che di colpo sembra essenziale conservare in v.o.; e si passa a indagare come Beckett abbia tradotto se stesso dal francese in inglese e viceversa, che cosa abbia modificato emigrando da una tradizione, da una cultura all'altra, quali sfumature abbia dovuto precisare o abbandonare nel transito; e la notizia che l'autore stesso si sia bloccato per circa un anno sulla versione inglese (dal francese) di Finale di partita non è certo incoraggiante.
Dietro ogni singola parola si intravede e poi si vede con crescente sgomento, una meticolosità ferrea, fanatica, che non lascia al caso neppure una virgola. È come accorgersi che quello stringato capannone per rottamature è opera in realtà di Brunelleschi. Una simile scoperta ha sul traduttore un effetto paralizzante. Nulla più suona giusto, e l'unica soluzione seria che si fa luce fra tanta avvilente impotenza a volgere questi testi, questi suoni, in italiano, è di riprodurli tali e quali, di trascriverli nell'originale, identici, come Pierre Menard fece con Don Chisciotte.
Ci si deve poi naturalmente accontentare di compromessi, sia pure raggiunti nei casi più irti con benevolo soccorso di Beckett, un uomo di cui i ritratti rendono piena giustizia all'affascinante fluidità di modi e movimenti, tra gli spigoli del suo piccolo appartamento parigino dietro il carcere della Santé, spoglio, nitido, metallico, quasi ospedaliero.
E della sua indulgente amabilità verso un giovane incosciente e ignorante conservo uno di quei ricordi che bruciano per tutta la vita. Gli chiedevo chi fosse la misteriosa Effi nominata in due dei suoi testi.
Ma era Effi Briest! Non conoscevo il romanzo di Fontane? No, non lo conoscevo, dissi senza arrossire. Beckett, altissimo, fragilissimo, sorridente, mi consigliò vivamente di leggerlo, quella povera eroina gli stava a cuore più di Emma Bovary.
Presi nota, pensando a una preferenza eccentrica di grande scrittore forse un po' snob. Arrossii dopo, e ancora dopo tanti anni arrossisco, con una certa indulgenza, ma irrimediabilmente, hélas.
Carlo Fruttero (da www.sistemamusica.it)