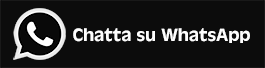Quando Beethoven ritorna verso il mondo
Un sospetto pesa sulla letteratura per pianoforte e orchestra, un'ipoteca di superficialità e di ricerca del successo a buon mercato che non risparmia neppure i cinque concerti di Beethoven.
Tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo, in effetti, il concerto solistico era il cuore delle "accademie", ovvero di quelle vaste forme di esibizioni musicali nelle quali rientravano anche sinfonie, arie da concerto, improvvisazioni, e che per gli autori rappresentavano l'unica vera alternativa al teatro d'opera in termini di celebrità e di guadagno, specie quando vi prendevano parte anche in veste di interpreti. A questa ferrea legge di mercato non si sottrasse Mozart, il tramonto della cui stella coincise con il declinare del successo dei suoi concerti, e non poteva sottrarsi neppure Beethoven. Lo testimoniano i suoi due "mozartiani" concerti per pianoforte d'esordio, il n. 1 in do maggiore op. 15 e il n. 2 in si bemolle maggiore op. 19, ma lo testimoniano anche i suoi lavori più maturi, con il culmine di spettacolarità ed esuberanza costituito dal Concerto n. 5 in mi bemolle maggiore op. 73, non a caso intitolato Imperatore dall'editore - e pianista a sua volta - J. B. Cramer. E tuttavia.
E tuttavia i conti non tornano, non tutto funziona in questa forma di contestualizzazione storica. I sospetti sulla presunta esteriorità dei concerti per pianoforte devono arrestarsi di fronte alla complessità di pagine che non si lasciano ridurre a una sola dimensione, ma che anzi moltiplicano in modo esponenziale la varietà dei loro motivi di interesse almeno a partire dal Concerto n. 3 in do minore op. 37, eseguito per la prima volta a Vienna nel 1803. Non c'è dubbio che coordinate come quelle della grandiosità e dello spettacolo facciano parte della loro ispirazione, tanto da fare degli ultimi concerti beethoveniani, in particolare del n. 3 e del n. 5, brani fra i più eseguiti di tutta la letteratura classica già a partire dalla prima metà del XIX secolo.
Eppure, mai in queste opere la monumentalità è fine a se stessa, mai il virtuosismo si avvolge nell'autocompiacimento o nella soluzione di facile effetto. Piuttosto, gli ultimi concerti per pianoforte e orchestra di Beethoven sembrano mettere in scena una dialettica storica che trasforma lo spettacolo stesso in una, e una sola delle sue componenti: non l'unica, dunque, né la più importante. Nel suo bellissimo libro incompiuto su Beethoven, Adorno ha parlato in questo senso di una "anticipazione della cultura di massa" che trova il suo contraltare in un movimento di "ritorno verso il mondo". Questo, però, non è separato dai suoi momenti più esuberanti e come opposto a essi, ma li abita in profondità, come una forza nascosta al loro interno. "Riappartengo alla terra!", recita la citazione dal Faust di Goethe, ed è solo uno degli esclamativi, delle speranze e degli imperativi che Beethoven visse, più o meno dolorosamente, lungo una curva continua che unisce le sinfonie e la musica da camera, il tono mondano dei concerti per pianoforte e quello infinitamente riservato degli ultimi quartetti per archi.
Non si tratta, dunque, di contrapporre al trionfalismo dei movimenti di apertura o alla leggerezza dei Rondò conclusivi lo spirito più introverso degli Adagio o dei Largo centrali. Bisogna piuttosto cogliere in ciascun movimento lo svolgersi di un processo che passa dall'ostentazione al lirismo e poi da questo, di nuovo, verso un nuovo sentimento di familiarità con il mondo. Così, scrive ancora Adorno, i finali dei concerti di Beethoven sembrano dire "ora non c'è più nessuna paura", mentre quelli di Mozart riflettevano una condizione che semplicemente "non conosceva paura". E sempre in questa prospettiva va collocata tutta una serie di espedienti compositivi con i quali Beethoven tende ad annullare la distanza tra lo strumento solista e l'orchestra, o meglio a far passare l'uno nell'altra e viceversa, come avviene con i passaggi staccati degli archi che quasi mimano la tecnica della tastiera, o con i lunghi trilli del pianoforte che quasi imitano i suoni tenuti dell'orchestra. La dimensione dello spettacolo fa parte di questa logica, non la contraddice. È quel che trascina Beethoven verso una superficie alla quale egli aspirava, poiché vi ravvisava non solo il luogo della banalità, ma quello ben più significativo del riconoscimento della propria appartenenza al presente.
Stefano Catucci (da www.sistemamusica.it)