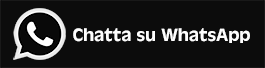Steve Coleman e il mito africano, una riflessione in libertà
Ascoltando la musica di Steve Coleman avevo spesso una sensazione che non riuscivo a definire, connessa al suo fraseggio sull'alto, che poi si riverbera sul resto del prodotto, come avviene sempre quando è all'opera una concezione estetica forte al punto di essere dominante. Poi, la lettura di un saggio presente nell'ultimo numero di Lenox Avenue - rivista del Center for Black Music Research dedita allo studio comparato delle arti - e l'ascolto dal vivo di Coleman a Pescara mi ha chiarito le idee: la musica di Steve Coleman non ha il sorriso.
La difficoltà a capire che provavo è connessa al fatto che non è musica triste, come non è, di solito, musica arrabbiata. Facile pensare alla rabbia, il fraintendimento del valore emotivo è un tranello nel quale cade spesso l'ascoltatore che non approfondisce la cultura degli afro-americani.
Ad esempio l'apparenza del blues lo ha spesso, nell'immaginario dell'appassionato bianco, associato alla depressione e alla rinuncia. Salvo poi ricredersi analizzando l'ironia che pervade i testi anche più drammatici o leggendo libri come "Stompin' the Blues" di Albert Murray: il blues è un esorcismo di ansie, paure e depressioni, il suo fine è affermare la forza vitale dovunque e comunque.
Per la rabbia il discorso è analogo. John Coltrane è stato più volte accusato di essere un artista arrabbiato e «Ascension» di aver concretizzato senza filtri questo stato d'animo. Logico, per chi ha vede la spiritualità secondo canoni ieratici che il cristianesimo ha importato in Europa, modellando la nostra tradizione musicale sulla base del canto gregoriano. Meno logico per chi viene dall'Africa, dove ridere durante una cerimonia funebre non è per forza disdicevole e inappropriato; o dove la visione del divino passa per meccanismi che il mondo occidentale ha dimenticato con la sparizione dei riti misterici (salvo ricuperarli col tramite della religiosità contadina, legata ancor oggi a schemi definiti durante il neolitico).
Così la musica di Steve Coleman non sorride perché il riso - presso gli Yoruba e altri popoli africani - non si addice all'uomo e alla donna virtuosi, ma a chi è infido. È musica molto simbolica, spesso matematica, che non accetta quanto può comprometterne la compattezza ed espunge, per quanto possibile, il lato americano della cultura afro- americana. Per questo il fraseggio al contralto di Coleman, che porta evidenti i segni del passaggio di Henry Threadgill, Ornette Coleman, John Coltrane e Charlie Parker, ne elimina la sensualità più americana - i portamenti, l'ampio vibrato, la sensibilità del balladeur seduttore - avvertibile ancora in Threadgill. Tutti elementi di disturbo, che Coleman riduce a minimo anche nei suoi collaboratori, pagando il prezzo di un'utopia africano-centrica in parte a-storica per chi, piaccia o no, è figlio della creolizzazione forzata di una razza sottoposta a deportazione e contaminazione genetica coatta.
Elementi finora temperati dall'uso della voce - difficile pensare a un canto più africano e americano di quello di Cassandra Wilson - e dalla ricchezza timbrica ben mostrata negli ultimi CD di Coleman.
L'erede di «On the Corner» e di «Dancing in Your Head» sembra puntare ora a una musica più dogmatica, forse meno ricca, ma, come si è visto a Pescara, è un work in progress, dall'esito tutto da scoprire.
Valerio Prigiotti (da www.allaboutjazz.com/italy)